Le Quattro di Richmond: la nascita clandestina di un sogno mondiale
Richmond, sud-ovest di Londra. Un pomeriggio d’autunno, il cielo è basso, il campo è umido. Non è il luogo dove tutto è cominciato. È il luogo dove tutto ha preso forma. Dove il rugby femminile ha smesso di essere clandestino e ha iniziato a sognare in grande.
Il Richmond Athletic Ground non è uno stadio, è un teatro di provincia. Un palcoscenico di erba e fango dove il rugby non si gioca: si respira. Il campo non ha spalti vertiginosi né luci accecanti. Ha tribune di legno che scricchiolano sotto il peso degli anni e delle storie. Ha una clubhouse che sa di birra, di maglie sudate, di racconti sussurrati davanti a un camino spento. Ha alberi che lo circondano come guardiani silenziosi, testimoni di mille placcaggi e di qualche sogno. Quando piove, il campo si trasforma. Non diventa ostile. Diventa vero. Il fango non è ostacolo, è complice. Le scarpe affondano, le ginocchia graffiano, ma nessuno si ferma. Perché a Richmond, il rugby è più di uno sport. È un rito.
Un giorno come tanti, fine di un allenamento. Quattro donne si ritrovano a bordo campo. Non c’è un piano. Non c’è un budget. Non c’è nemmeno una domanda. C’è solo una scintilla. Deborah Griffin, Alice Cooper, Sue Dorrington, Mary Forsyth. Quattro rugbiste, quattro compagne di squadra, quattro visionarie. Non hanno titoli, non hanno sponsor, non hanno appoggi istituzionali. Ma hanno qualcosa che vale di più: hanno una visione. “E se facessimo una Coppa del Mondo?” Non è una provocazione. È una dichiarazione d’intenti. È il primo passo verso qualcosa che nessuno ha mai osato immaginare.
Le “Quattro di Richmond” si mettono al lavoro. Di notte, dopo il lavoro. Di mattina, prima di timbrare. Riunioni alle otto, compiti divisi, poi via in ufficio. Nessuna esperienza, nessun manuale. Solo passione. E ostinazione.
Quando si presentano all’International Rugby Board, la risposta è gelida. Una sala riunioni imponente, un tavolo di legno che sembra un altare. Parlano. Espongono. Sognano. Ma la riunione dura poco. “Non volevano avere niente a che fare con noi.” Il rugby femminile, per loro, non esiste. Non è uno sport. È una distrazione. Ma le quattro non si fermano. Anzi, accelerano.
Organizzano tutto da sole. Finanze, logistica, comunicazione. Nessun budget. Nessun aiuto. Solo fax. Fax inviati “mattina, mezzogiorno e notte” per contattare squadre in tutto il mondo. Canada, Francia, Italia, Giappone, Russia, Nuova Zelanda, USA… dodici nazioni rispondono. Dodici bandiere si alzano.
L’Italia inizialmente dice no. La Federazione non vuole che le donne giochino. Ma le giocatrici insistono. Si autorganizzano. Si presentano comunque. E la Federazione, a quel punto, non può che riconoscerle. Erika Morri, ex giocatrice, lo racconta così: “Era assolutamente un movimento clandestino. Sentivamo che qualcosa stava cambiando.”
L’Inghilterra è troppo cara. Troppo complicata. Troppo chiusa. Il Galles, invece, apre le porte. Il rugby è nel sangue, nelle vene, nei pub. Cardiff Arms Park offre la finale. I campi locali ospitano le partite. “I gallesi non avrebbero potuto essere più accoglienti.” Il torneo prende forma. Ma resta il problema più grande: i soldi.
Promettono vitto e alloggio alle squadre. Ma il conto sale: 35.000 sterline. Una cifra folle. Le aziende rifiutano. Una dice: “Il rugby femminile è uno sport di partecipazione, non uno sport per spettatori. Buona fortuna.” Le squadre decidono di pagare da sole. Le russe non possono portare denaro fuori dall’Unione Sovietica. Vendono bambole e vodka sui gradini del municipio. Cardiff risponde con donazioni. Buoni Marks & Spencer. Solidarietà.
“Non era tanto il fatto che la stavamo gestendo con pochi spiccioli – la stavamo gestendo con un filo sfilacciato.” Ma quel filo tiene. Tiene tutto.
4 aprile 1991. Cerimonia d’apertura. Cardiff Arms Park. Le giocatrici entrano in campo. Liza Burgess piange. Erika Morri sorride. “Per la prima volta ci sentivamo atlete. Pioniere.”
I media sono scettici. “Sarà una sciocchezza. Ragazze che rotolano nel fango.” Ma il torneo funziona. Le partite sono combattute. Le emozioni vere. La finale vede gli USA battere l’Inghilterra 19 a 6. Davanti a tremila spettatori. Non è il numero che conta. È il segnale. Il rugby femminile ha fatto rumore. Ha fatto storia.
Il torneo chiude in perdita. 6.756 sterline. I debiti spaventano. Si parla di pignoramenti. Ma la Rugby Football Union interviene. Copre le spese. Le quattro donne tornano alle loro vite. In silenzio.
“Debs si isolò per sei mesi. Alice perse il lavoro. Il mio matrimonio finì. È stato difficile. Il sogno si è realizzato, ma a un grande costo personale.” Griffin parla di stress, di notti insonni. Cooper dice: “Sono stati nove giorni implacabili e mortali.” Dopo il torneo, non ne parlano più. “A dire il vero, penso che fossimo traumatizzate.”
Trent’anni dopo, tornano a Cardiff Arms Park. Presentano targhe. Ricevono applausi. Ma il vero riconoscimento è altrove. È nei volti delle ragazze che oggi giocano davanti a folle da record. È nei sogni che si sono moltiplicati.
Le squadre che ora giocano si ergono sulle spalle di quattro donne incredibili che hanno condiviso una visione. Deborah Griffin lo dice con semplicità: “Volevamo solo che più donne potessero giocare. Ora lo fanno.”

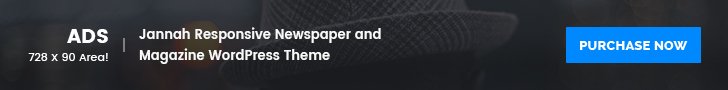






Nessun commento